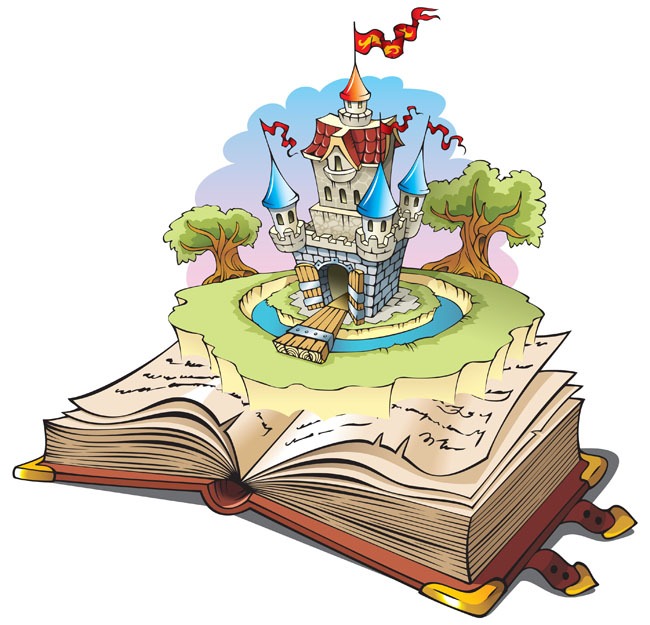
Fiaba e favola come percorso di crescita attraverso la drammatizzazione e il gioco.
La magia della narrazione è una parte importantissima del laboratorio di teatro emozionale, e soprattutto in quello per bambini.
Questo perché Il Teatro, sia per grandi che per piccoli, ridotto al massimo nella sua essenza, è il desiderio di narrare e trasmettere qualcosa a qualcuno. Quindi quando facciamo una lezione di Teatro con i bambini, oltre a vari esercizi di movimento col corpo, raccontiamo una storia, quale sia questa storia dipende molto dall’età. Ma una cosa è certa e vale dai 2 ai 122 anni.
Mettete un gruppo di persone sedute in un posto, attendete che si faccia un attimo di silenzio, aprite le vostre labbra e fate uscire con tono caldo, calmo, ritmato, intenso queste magiche paroline: “C’era una volta, tanto tempo fa….” Sono sicuro che il 98% dei presenti penderanno dalle vostre labbra. E se siete particolarmente ispirati pure il restante 2% in pochi minuti sarà in ascolto di quello che narrate:
Si, avete indovinato. Se la storia è una fiaba state “mettendo il Carico su una briscola” e magari è proprio una di quelle che ci narravano nonne e nonni, mamme e babbi quando eravamo piccoli. Negli anni ho spiegato il potere delle fiabe ad adulti di ogni età, facendo anche esempi raccontando una fiaba breve velocemente, e in giorni in cui ero particolarmente ispirato, me ne ricordo alcuni che al “e vissero tutti felici e contenti…” erano rapiti dall’ascolto con il ditino in bocca, perfino alcuni omaccioni grandi e grossi, oltre ai bambini.
Ed allora ecco a voi un breve saggio sulla Fiaba e il gioco simbolico di drammatizzazione, che ho scritto qualche annetto fa per formare i nostri operatori di laboratori teatrali e per i corsi di formazione per insegnanti interessati a questo mondo fantastico .
Fiaba e favola
come
percorso di crescita
attraverso
la drammatizzazione e il gioco
di
Marcello Muccelli
fiaba/favola animazione e gioco simbolico.
Per secoli i nonni, le nonne, le mamme e i papà hanno allietato i bambini raccontando loro le fiabe e le favole [i], esse sono usate da tempi antichi come strumento per trasmettere conoscenze, valori, suscitare sicurezza, stimolare viaggi in mondi immaginari, ma soprattutto per sdrammatizzare e superare paure “nascoste “. Infatti, esse parlano alla parte più profonda di noi.
Jung trova gli archetipi [ii] in tali racconti orali, tramandati attraverso il “fiume del tempo”.
Per Carl Gustav Jung tali archetipi sono immagini primarie ed un modello originale universale delle idee. Egli ipotizza che ogni individuo nasca con impostazioni psichiche trasmesse per vie ereditarie, ma non solo: ipotizza che ogni individuo possieda un inconscio collettivo comune a tutto il genere umano.
Gli archetipi, che sono più attinenti alla fiaba rispetto che alla favola, “spesso rivelano la loro presenza per mezzo di immagini simboliche “ come Jung scrive in “L’uomo e i suoi simboli”(Longanesi Milano 1980,pag 52) e allora tali immagini assorbite e rielaborate vengono integrate nella coscienza.
Ecco che le fiabe, perciò, cariche di simboli per eccellenza, tramandate da tempo immemorabile , aiutano i bambini nel loro percorso di crescita.
V.J. Propp grazie al suo studio, trova nelle fiabe solo 7 tipologie di personaggi e 31 funzioni e quest’ affermazione risulta vera per qualunque fiaba di qualsiasi parte del mondo [iii].
Simili in tutti i paesi, dove l’uomo si è stabilito, tali racconti orali così affini al mito, sono narrati e fatti “giocare” dall’animatore teatrale al bambino ed al fanciullo con la tecnica della drammatizzazione, con l’obiettivo di dare loro strumenti utili per superare i piccoli o grandi problemi di tutti i giorni.
Con la drammatizzazione l’animatore usa il gioco simbolico, quello che i bambini già usano spontaneamente per esplorare la realtà e le relazioni.
Il mondo fantastico che si crea con le fiabe e la drammatizzazione, è un “posto sicuro” in cui sperimentare, fallire o riuscire. È il luogo dove il Drago viene sconfitto, l’Eroe salva la Principessa, il Male quindi viene distrutto mentre il Bene trionfa .
È il luogo fantastico in cui possiamo festeggiare con un bel ballo finale in cui tutti vivono a lungo felici e contenti.
Come scrive nell’apertura di Coraline ( oscar Mondatori Milano,2004 ) lo scrittore Neil Gaiman citando G.K. Chesterton “Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, (loro sanno già che esistono: sono la rappresentazione delle loro paure) Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si possono sconfiggere “ .
Il simbolismo è quindi presente nelle fiabe, sia nei vari personaggi :
l’eroe, l’antagonista, il mandante, il falso eroe, il donatore, l’aiutante, colui o colei che deve essere salvato, che nelle varie ambientazioni: boschi, sotterranei di castelli, isole sperdute ecc.
Prendiamo ad esempio Cappuccetto rosso.
Cappuccetto rosso deve crescere, deve quindi affrontare un percorso lineare in cui sviluppare le sue qualità, un vero e proprio percorso di crescita e iniziatico:
· abbandona la casa materna con del cibo per la nonna;
· ascolta le raccomandazioni della madre e si dirige nel bosco;
· disattendendo ciò che la madre le ha suggerito si fida del lupo;
· successivamente viene ingerita in un boccone assieme alla nonna dallo stesso Lupo .
· Un cacciatore, poi, passando dalla casetta della nonna, si accorge dal suo russare della presenza del lupo. Lo uccide e libera la nonna e Cappuccetto rosso
Veloce interpretazione con riferimenti antropologici e simbolici:
l’età dell’infanzia è finita, e la bambina deve iniziare a compiere qualche atto da adulta, ma come un eroe che si rispetti prepara prima il suo bagaglio ( si mette il cappuccio, prende le focacce) ascolta le indicazioni del mandante (la madre) e va nel bosco ( le difficoltà della vita), incontra il lupo, che rappresenta l’antagonista. Quest’ ultimo usa l’inganno come strumento per catturarla, ma ciò è anche “necessario”, indispensabile per la cerimonia iniziatica della bambina che deve venire sottoposta a prove di abilità e di riflessione.
Invece di mangiarla subito, come logicamente farebbe un vero predatore, egli la precede a casa della nonna e inghiotte quest’ultima divenendo egli stesso il luogo di iniziazione ( la” grande ava saggia “ entra nella caverna ed attende l’inizianda) .
Quando arriva, Cappuccetto rosso, pone delle domande al lupo, chiedendogli spiegazioni circa i suoi lineamenti, non riconoscendo nel suo aspetto qualcuno di conosciuto, tanto meno la sua familiare (questa serie di domande rappresenta così l’incertezza del bambino durante i passaggi da un’età all’altra). Inoltre, per quanto riguarda il “travisamento” rituale con maschere e costumi, dobbiamo ricordare che certe “iniziazioni” le davano gli sciamani e le sciamane, coloro che erano in contatto con il mondo delle divinità e della magia rituale, unici possessori di determinate conoscenze, che erano considerate di vitale importanza per il gruppo tribale e che dovevano essere custodite gelosamente da una ristretta cerchia di individui essendo misteri considerati arrivare dalle divinità.
Le domande che essa pone, sono infatti tentativi di darsi risposte rassicuranti e rimandare il momento del passaggio da una fase all’altra. In questa fase di dubbio, di crisi e d’incertezza il lupo la inghiotte ( non può essere più posticipato l’ingresso fra gli adulti). La bambina avrà presto il menarca, il fanciullo diverrà più forte ( segni di crescita fisica si stanno presentando e stanno trasformando il loro corpo ) entreranno nel mondo degli adulti e potranno aiutare il gruppo tribale nella raccolta o nella caccia. La piccola entra nella caverna ( la pancia del lupo) dove l’anziana saggia l’attende per trasmetterle conoscenze e traghettarla alla maggiore età. Il sonno del lupo è il tempo della stasi, del letargo di attesa in cui i semi simbolici vengono portati a maturazione.
Cosa succede, e cosa rappresenta il momento in cui il cacciatore le libera: il tempo da trascorrere nella caverna è finito, la saggia più anziana ha trasmesso il suo sapere, oppure il capo tribù, o il re, o lo sciamano, o la parte maschile o femminile del gruppo accetta fra gli adulti la piccola interrompendo la reclusione iniziatica, frantumando fisicamente i sigilli che bloccano l’entrata delle capanne o delle grotte dove gli iniziandi erano reclusi con il cibo che si erano portati; ecco il perché del taglio del ventre del lupo per liberare la bimba e la nonna. Ormai il luogo di reclusione ha raggiunto il suo scopo e non serve più, e vi è una vera e propria rinascita.
Cappuccetto rosso viene raggiunta dalla madre e viene organizzata una grande festa ( il rito di passaggio è avvenuto, ora un altro adulto è arrivato nel gruppo e potrà partecipare delle attività degli adulti e questa è una buona motivazione per festeggiare ) .
L’animatore teatrale quindi, come dicevamo sopra, con lo scopo di fornire ai bambini gli strumenti per superare i piccoli o grandi problemi di tutti i giorni, userà la fiaba, facendoli vivere in situazioni immaginarie e in uno spazio sicuro e protetto dove potranno sperimentare varie vicissitudini e immedesimarsi nei personaggi, riuscendo a superare le peripezie e giungere ad un lieto fine.
Ecco quindi che la lettura animata in biblioteca, il gioco teatrale, il racconto orale delle fiabe e delle favole, la drammatizzazione trasportano i bambini, cavalcando le ali della fantasia, attraverso deserti, paludi, foreste stregate, mari in tempesta, caverne tenebrose, monti aguzzi e remoti, mentre sono comodamente seduti su un cuscino in biblioteca oppure seduti in classe.
È questo un momento sia corale che individuale, in cui le piccole anime dei bambini e dei fanciulli sbocciano alla vita.
Ricordiamo che per i bambini “il gioco” è strumento basilare e imprescindibile per la crescita. Quindi dopo il racconto ci accingiamo a drammatizzare ciò che si è ascoltato .
Il “giocare” la fiaba, il portarla in scena è definito appunto drammatizzazione; la drammatizzazione è quindi quell’insieme di azioni che un bambino compie nel rappresentare, in uno spazio scenico, ciò che ha ascoltato grazie alla guida dell’animatore. Mentre impersona i ruoli dei diversi attori della fiaba o della favola, mette in atto il gioco simbolico, drammatizzando, nella scena, il suo vissuto interiore, che viene rivissuto, elaborato e contemporaneamente superato. La fiaba, come il gioco simbolico, è strumento di crescita. È catarsi.
[i] Fiabe e favole sono nate entrambe come forma di narrazione orale, ma anche se hanno molte caratteristiche comuni ne hanno alcune che ci permettono di classificarle: la maggior parte delle fiabe hanno una strutture lineare e progressiva del racconto, in cui il finale è sempre felice (hanno tutte un lieto fine),la maggior parte delle favole hanno una struttura quasi ciclica e spesso non hanno il lieto fine, poiché tendono ad insegnare una morale .
[ii] dal greco Archè: originale e Tipos: esemplare, modello.
[iii] Vladimir Jakovlevič Propp è stato un antropologo russo nato nel 1895 e morto nel 1970, egli nella sua opera “ Morfologia della fiaba “ ipotizza che ogni fiaba, indipendentemente dal luogo di origine e da quale cultura essa provenga, si possa introdurre in uno schema in cui i personaggi che prendono vita al suo interno sono 7 e le varie funzioni ( le azioni o reazioni ) che questi compiono durante il racconto, possano essere riconosciute, siano esse 4, 5 o più, in un elenco formato al massimo da 31. Analizza un centinaio di fiabe russe per provare la sua tesi dopo di che egli descrive 7 tipi di personaggi, che, indifferentemente dal fatto che siano animali, persone reali o immaginarie come: fate, stregoni, mostri o altro ancora, si possono ritrovare a seconda delle azioni che compiono in questi 7 personaggi: l’eroe, l’ antagonista, il mandante, il falso eroe, l’aiutante, il donatore, la principessa/colui che va salvato. Questi personaggi compiono alcune azioni durante la fiaba le quali si possono ritrovare tutte in uno schema di 31 funzioni: 1) allontanamento 2) divieto 3) infrazione 4) investigazione 5) delazione 6) inganno 7) connivenza 8) danneggiamento (o mancanza) 9) mediazione 10) consenso dell’eroe 11) partenza dell’eroe 12) l’eroe messo alla prova 13) reazione dell’eroe 14) conseguimento del mezzo magico 15) trasferimento dell’eroe 16) lotta tra eroe e antagonista 17) marchiatura dell’eroe 18) vittoria sull’antagonista 19) rimozione della sciagura o della mancanza iniziale 20) ritorno dell’eroe 21) la sua persecuzione 22) l’eroe si salva 23) l’eroe arriva in incognito a casa 24) le pretese del falso eroe 25) all’eroe è imposto un compito difficile 26) l’ esecuzione del compito 27) il riconoscimento dell’eroe 28) lo smascheramento del falso eroe o dell’antagonista 29) la trasfigurazione dell’eroe 30) la punizione dell’antagonista 31) le nozze dell’eroe.
Le funzioni non necessariamente hanno uno svolgimento dalla prima all’ultima, si possono invertire e potremmo anche non trovarne alcune in certe fiabe e trovarle invece in un’altra, ma tutte si ritrovano come tipologia in queste 31 qui sopra. Per uno studio più approfondito si consiglia Morfologia della fiaba di V J Propp Newton Compton editori Roma 1976
4 Il ballo stop è un gioco corale in cui i bambini si scatenano in una danza come più gli piace, e si fermano, immobili come statue, quando l’animatore ferma la musica, imitando le posizioni che l’animatore gli suggerisce come ad esempio: ”Quando fermo la musica tutti con le mani sulla testa” o sul naso, o sulla pancia, sul mento ecc.
Questo gioco serve per aiutarli ad apprendere il nome delle varie parti del corpo.
Bibliografia (consigliata)
Morfologia della fiaba di V J Propp Newton Compton editori Roma 1976
Le radici storiche dei racconti di fate / V J Propp Torino : Einaudi 1949.
Il mondo incantato: uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe / Bruno Bettelheim. – Milano : Feltrinelli, 2000
Grammatica della fantasia : introduzione all’arte di inventare storie / Gianni Rodari. – San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi
Il ramo d’oro, James Frazer
Homo Ludens, Johan Huizinga.




